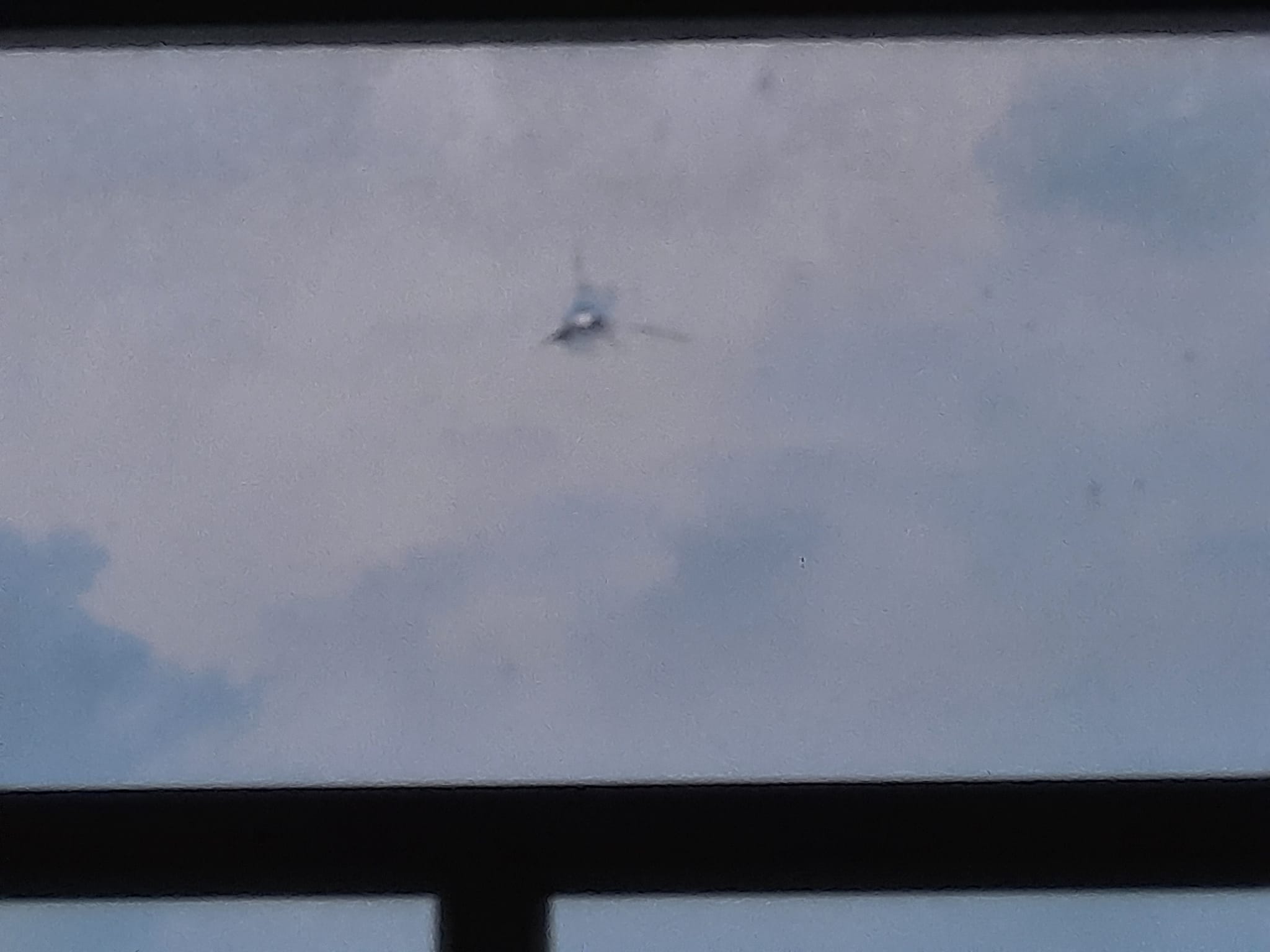Sono andato molte volte nei Territori Palestinesi occupati da Israele, in qualità di anestesista pediatrico, a operare bambini cardiopatici, e ad insegnare ai colleghi locali le nostre tecniche, prima all’ospedale Al Makassed di Gerusalemme, sulla cima del Monte Degli Ulivi, e poi all’ospedale Europeo di Gaza a Khan Yunis.
Le missioni sono organizzate dal Palestine Children Relief Fund, una ONG intrrnazionale, e supportate dalla Fondazione Monasterio dell'Ospedale del Cuore e dalla regione Toscana.
Sono state esperienze molto positive per me: l'intesa e la collaborazione con i colleghi locali sono state splendide, e i risultati degli interventi molto buoni.
Dopo alcuni anni l’ospedale Al Makassed, con cui collaboravamo i primi anni, ha cominciato ad essere autonomo, e non aveva più bisogno di noi, perché era in grado di eseguire più di duecentocinquanta interventi di cardio-chirugia pediatrica di media complessità, con risultati dignitosi.
Allora abbiamo deciso di tentare di fare lo stesso all'interno della striscia di Gaza, sottoposta ad un severo embargo su uomini e merci fin dal 2006 e, dal 2012 fino ad oggi, ogni anno, abbiamo eseguito almeno due missioni, fino al 2020, quando siamo stati costretti ad interromperle, per il COVID, e abbiamo ripreso nel 2022.
La guerra in queste terre martoriate è stata quasi ininterrotta.
In media ogni sei mesi c’è stato un lancio di missili da parte di Hamas verso Israele, ed una risposta con bombardamenti da parte di Israele. Più o meno ogni due anni la situazione si aggravava con lanci più numerosi e risposte con blitz di terra o addirittura massicce invasioni dell’esercito, che entrava in Gaza alla ricerca delle cellule di Hamas.
Nel 2015 c’è stata una guerra terrestre causata dal rapimento di un soldato israeliano. I suoi commilitoni sono entrati in massa, e hanno quasi distrutto il campo profughi di Jabalìa, senza riuscire a trovare il loro commilitone, liberato solo successivamente con uno scambio di prigionieri. Poco dopo c’era una delle nostre missioni, senza problemi, perché l’invasione non aveva raggiunto il sud della striscia. Nel percorso di ritorno verso il check-point di Erez, l’autista del pulmino ci ha fatto transitare da Jabalìa, dove abbiamo potuto vedere con i nostri occhi gli effetti della guerra. Molte case sventrate, altre ridotte ad enormi buchi neri nel terreno. Rovine dappertutto. I pochi muri ancora in piedi crivellati da colpi così vicini tra loro da essere indistinguibili l’uno dall’altro. I pochi superstiti smarriti, che cercavano di recuperare la poche cose riutilizzabili.
Oltre ai morti la guerra causa infinite disabilità. Passando dal porto di Gaza City, abbiamo incontrato due ragazzi sui vent’anni, entrambi amputati di una gamba a partire dalla coscia, l’uno mancava della destra, e l’altro della sinistra. Si assomigliavano, erano vestiti uguale e, per risparmiare, avevano condiviso un paio di scarpe, di cui uno indossava la destra e l’altro la sinistra. Ma la cosa più struggente è stata vederli partire su una vecchia motocicletta, seduti uno dietro l’altro: uno guidava e cambiava, l’altro frenava con il freno a pedale.
Ovviamente il mercato del pesce, vicino alla diga foranea, era stato colpito da un missile, e la stessa diga foranea, che teneva al riparo una piccola flotta di pescherecci, era stata smantellata da varie bombe, che l’avevano quasi distrutta.
Ora entrambe le infrastrutture sono state ricostruite, e sono pronte ad essere distrutte di nuovo dalla guerra in corso.
In questi anni la situazione nella Striscia si è fatta sempre più precaria: la corrente elettrica in ospedale è disponibile di continuo, ma la popolazione ne ha solo per un’ora al giorno, e non tutti i giorni. L’acqua potabile è garantita da distributori mobili, perché quella dei rubinetti non è affidabile, a causa della salinizzazione delle falde acquifere e dell’inquinamento generato dai vari bombardamenti.
Ci sono alcune automobili, di proprietà delle persone più ricche, e dei dirigenti delle ONG straniere, ma, in larga maggioranza, i trasporti sono assicurati da pulmini che fungono da taxi collettivi. Comunque quasi tutti si muovono a piedi, o a dorso di mulo, e anche le merci si spostano su carretti a trazione animale.
L’illuminazione stradale è largamente insufficiente, a tal punto che ogni nostro spostamento è un’avventura, al temine della quale ci affrettiamo a mentalmente a baciare la terra all’arrivo.
Le cardiopatie congenite, in questo popolo, sono statisticamente più numerose rispetto alle percentuali previste dai manuali, probabilmente a causa di malnutrizione materna, inquinamento ambientale e, forse, di matrimoni tra consanguinei.
La trafila per ottenere il permesso per accedere alla Striscia è lunga e complessa, e si addentra inopinatamente nella ricostruzione dell’albero genealogico, almeno fino ai nonni.
L'unico check-point da cui possano passare le persone da Israele verso la striscia è Erez, all’estremo nord della striscia. L’altro valico è all’estremo sud, nel villagio di Rafah, tagliato a metà dal muro, che separa la parte egiziana da quella palestinese. Questo passaggio si apre molto di rado, perché, nonostante i proclami reboanti, il governo egiziano non intende permettere ai palestinesi di stabilirsi nel suo territorio. Quindi questa gente non può uscire verso Israele, dove non sono graditi per definizione, e neppure verso l’Egitto, che, a parole li rispetta e li ama, ma, nella pratica non li vuole. Se un giovane di Gaza vuole studiare o specializzarsi all’estero, deve ottenere il permesso dagli israeliani di uscire da Erez, e, in un pullman da cui non può scendere, deve raggiungere il valico sul fiume Giordano al Ponte di Allenby nei Territori Palestinesi, varcato il quale difficilmente gli sarà permesso di tornare in queste terre.
Il posto di controllo di Erez chiude verso le 17, e non ci sono voli praticabili dall’Italia per arrivare a Tel Aviv e poter raggiungere il valico in tempo. Quindi, prima di entrare nella striscia, si deve andare a dormire in albergo a Ramallah, e la mattina dopo, verso le 7, si parte per Erez, dove si arriva dopo un paio d’ore.
Il check-point è una specie di enorme stazione per gli autobus, con una serie di locali che sembrano biglietterie, e un grande cortile davanti, recintato con una grossa palizzata di ferro, con un solo accesso. Si aspetta davanti a questo cancello per un tempo non precisabile, poi un funzionario ritira i passaporti e i permessi, li esamina con cura e calma, e, finalmente, permette l’accesso al cortile, sorvegliato da atletici giovanotti non in divisa, armati fino ai denti. Da lì si accede ad un grandissimo salone, e si capisce che quelle che sembravano biglietterie sono posti di controllo. Il primo serve per ottenere il visto militare, a testimonianza del fatto che le autorità israeliane ritengono comunque Gaza un territorio militarmente occupato. Poi i bagagli vengono fatti passare attraverso un metal detector e ne vengono controllati accuratamente i contenuti.
Ogni volta che si passa di lì per noi c’è incertezza, perché la maggior parte degli strumenti nelle nostre valigie potrebbero essere usati come armi. Qualche volta mi è capitato di dover discutere, con vari funzionari, sempre educatissimi, ma estremamente puntigliosi, salendo nella gerarchia fino al responsabile del check-point, ma il materiale, per il quale chiediamo il permesso con mesi di anticipo, non è mai stato bloccato.
Questa è la ragione per cui preferiamo portare con noi quello che ci serve: spedire un container è possibile, ma costoso, e sconsigliabile: verrebbe immobilizzato alla frontiera, e potrebbe facilmente essere respinto.
Infine sia entra in un altro salone, dove si devono mostrare ancora una volta i documenti, compreso il visto militare, ad un funzionario, che li verifica , e ci fa anche qualche domanda: “Che lavoro fate? Perché siete qui? Dove dovete andare? Chi vi manda?”
Finalmente si passa oltre, e comincia l'attraversamento di un labirinto, con tornelli ad ogni curva, molto difficili da superare con le nostre pesanti valigie piene di attrezzature. Alla fine si arriva all’aperto, all’interno della Striscia. C’è una strada che percorre la terra di nessuno, lunga quasi due chilometri, circondata, dai due lati e sopra la testa, da una sequenza di robuste sbarre di ferro, modello carcere, che la fanno assomigliare ad una gabbia. Lo storico Ilan Pappe, un ebreo israeliano dissidente, definisce la striscia: "il penitenziario più grande del mondo". Lui qui non c’è mai stato, ma coglie nel segno. Davanti c’è una pianura incolta con qualche gregge di pecore, e dietro, a perdita d’occhio c’è il muro, che circonda entrambi i lati corti della striscia di Gaza, liscio, di cemento, altissimo, intervallato da torrette dotate di micidiali mitragliatrici a fuoco automatico, che si attivano se qualcuno si avvicina a meno di 1 km. Alla fine della gabbia c’è il posto di controllo di Fatah, l'interlocutore di Israele nelle questioni palestinesi, che nella striscia non ha molti seguaci, perché gli abitanti hanno votato in massa a favore del gruppo concorrente, Hamas. Questo, ci hanno spiegato, essendo nella lista nera dei movimenti terroristici internazionali, non può intrattenere rapporti di nessun tipo con l'esterno, quindi Fatah ha un posto di frontiera formale, ma i controlli sostanziali li fanno quelli di Hamas, 1 km più avanti. Il loro check-point è molto diverso sia da quello israeliano che da quello di Fatah. È poco militaresco, e un po’ disordinato. Controllano superficialmente le valigie, e sono interessati solo agli eventuali alcoolici, severamente proibiti. Questo lassismo potrebbe essere dovuto al fatto che a questo punto noi non siamo più soli, perché il direttore locale del PCRF, che ci è venuto incontro fin dall’uscita di Erez, ci accompagna, e risponde alle domande per noi.
Il lavoro all’European Gaza Hospital di Khan Yunis per noi è molto intenso: si fanno interventi dalla mattina alla sera, e di notte siamo sempre reperibili per le eventuali complicazioni. I nostri alloggi sono nella scuola per infermieri, adiacente all’ospedale. Le notti sono interrotte dalle preghiere dei muezzin, ad intervalli regolari. E, meno spesso, dai boati delle esplosioni delle bombe con cui si esercitano quelli di Hamas, o sganciate dai bombardieri israeliani. Ma il nostro ospedale finora non è mai stato colpito, quando noi eravamo presenti.
Alla fine della settimana di lavoro ci sono i commoventi addii con i colleghi e si comincia già a parlare della prossima volta. Il percorso di riavvicinamento a Erez è un po’ triste, ci consola il bagaglio di ricordi ed esperienze che abbiamo accumulato. Il passaggio del valico in direzione inversa non è uno scherzo. La coda delle persone in uscita si è un po’ infoltita negli ultimi tempi. Per regolamento noi delle ONG passiamo per ultimi. Prima i malati, poi i lavoratori, infine noi. Questo significa un’attesa di ore, davanti al muro, senza la possibilità di sedersi, e con poco riparo dall’eventuale pioggia. Quando finalmente si entra nel salone in uscita verso Israele è tutto diverso. Il materiale non c’è più, perché lo abbiamo lasciato nel magazzino dell’ospedale, per usarlo le prossime volte. Ci consegnano un foglio, dove dobbiamo dichiarare tutto il materiale elettronico che portiamo con noi , dal cellulare al rasoio da barba, allo spazzolino elettrico, alle prolunghe. Poi si entra in un salone, dove ci fanno togliere giacche e scarpe. La nostra valigia deve essere aperta, e viene squadernata dentro una specie di tinozza, con accanto le scarpe e la giacca. Possiamo tenere in mano il passaporto ed i soldi, ma io lascio tutto nella tinozza, e non mi è mai stato rubato nulla.
Qui i nostri interlocutori diretti sono palestinesi, mentre gli israeliani li vediamo attraverso le vetrate anti-esplosione, lontani, al secondo piano sulla parete davanti a noi. Tra noi e loro ci sono almeno cinquanta metri di distanza. Si capisce che il sistema è costruito per evitare che si facciano male in occasione di un eventuale attentato dinamitardo. Ci mettiamo in coda davanti allo scanner, che è di quelli total-body. Quando si entra, bisogna sollevare le braccia ed allargare le gambe, poi qualcosa ci gira intorno rapidamente, e, se si accende una luce verde, possiamo passare e rientrare in Israele, ma, se si accende la luce rossa, uno dei soldati dal secondo piano cerca di attirare la nostra attenzione, e, di solito, ci dice di ricontrollare in tasca, perché hanno visto qualcosa di strano. Ad un collega hanno contestato di avere qualcosa attaccato alla schiena, ma era un grosso neo. A me hanno contestato qualcosa di metallico sui fianchi, ma non lo trovavo. Allora mi hanno indirizzato verso il percorso dei cattivi, e, dopo una serie di porte, con il semaforo prima rosso poi verde, mi sono ritrovato in una specie di segreta, dove un giovanotto foruncoloso, stando di là da un vetro, mi ha interrogato su cosa facevo a Gaza, e poi, preceduto da un energumeno con un fucile mitragliatore grande come quelli dei cartoni animati giapponesi, è entrato e mi ha intimato di togliermi i pantaloni, li ha passati nel metal detector, e li ha esaminati con la paletta che riconosce le polveri esplosive. Ha trovato le fibbie che il body scanner aveva identificato, me le ha fatte vedere da lontano, ha abbandonato i miei pantaloni e se n’è andato senza una parola, lasciandomi lì una ventina di minuti. Poi è ricomparso di là dal vetro, mi ha aperto un’altra porta, questa senza semaforo, che portava fuori al recupero bagagli. Avendo fatto il percorso dei cattivi, quella volta la mia valigia era stata esaminata con estrema cura, avevano anche cercato qualcosa tra una pagina e l’altra dei miei libri...
Abbiamo cominciato questa avventura nel 2013 e non ci siamo ancora abituati alla povertà di questa gente, ma ammiriamo la loro straordinaria gioia di vivere.
Assieme a loro abbiamo costruito un reparto di cardiochirurgia pediatrica dal niente, portando valigie su valigie di materiale donato dalle aziende farmaceutiche e dalla Fondazione Monasterio. Lentamente, In questi dieci anni, abbiamo cominciato a capire qualcosa del popolo della Striscia.
Ci hanno raccontato che qui furono ammassati gli sfollati della guerra israelo-palestinese del 1948, fuggiti o scacciati dai loro villaggi. Erano sotto la responsabilità delle Nazioni Unite, e dell’organizzazione per i rifugiati. Nella guerra del 1966, la Striscia fu conquistata dagli israeliani, assieme a tutta la penisola del Sinai.
Dopo la guerra del Kippur del 1973, in seguito agli accordi di Camp David, tra il presidente egiziano Sadat e il primo ministro israeliano Begin, sotto l’egida del presidente Carter, il Sinai venne restituito agli egiziani. Per questa pace entrambi ricevettero il premio Nobel nel 1978 (e per il medesimo accordo di pace, nel 1981, Sadat fu ucciso da un jihadista). Di conseguenza le colonie che si erano insediate nel Sinai furono trasferite nella Striscia. Erano 23, si posizionarono senza soluzione di continuità sul mare, con i loro impianti di dissalazione dell'acqua e le coltivazioni idroponiche di fragole, vendute in tutto il mondo. Facevano anche accoglienza turistica, ed erano diventati una specie di Versilia, attirando turisti da tutto Israele. Gli sfollati arabo-palestinesi del 1948, del 1966, e del 1973 furono fatti arretrare più all’interno, su una striscia di terra più sottile e senza sbocco al mare. Ma continuarono a crescere e moltiplicarsi.
Nel 2005 Sharon, il temibile ministro della difesa di Israele, ordinò di sgomberare i coloni dalla Striscia, perché non erano più difendibili. Molte furono le proteste tra gli israeliano, ma a tutti gli osservatori sembrò una decisione inevitabile.
Le colonie furono abbandonate, e gli abitanti della Striscia ebbero la possibilità di transitare liberamente per il loro fazzoletto di terra, e poterono finalmente avvicinarsi al mare.
Tanta fu la sorpresa che numerosi morirono annegati, perché si addentrarono in acqua senza saper nuotare.
Ancora oggi alcuni stabilimenti balneari costruiti dagli israeliani sono visibili. Invece i dissalatori e le colture idroponiche non sono utilizzabili, perché furono quasi tutti distrutti dai dirigenti politici di Hamas, in una delirante e distruttiva vendetta nei confronti dell’odiato nemico.
Il tasso di natalità a Gaza è ampiamente superiore a quello d'Israele. E anche a quello della maggior parte degli altri paesi del mondo. Da quando sono stati chiusi lì dentro, i palestinesi si sono raddoppiati. Purtroppo a questa esplosiva vitalità la classe dirigente che si sono scelti non ha saputo rispondere con saggezza e lungimiranza. Le sovvenzioni dei paesi arabi ricchi, come il Qatar e le altre petro-monarchie, compresa l'Arabia Saudita, vengono impiegate per acquistare armi, e non per far crescere l’imprenditoria civile e la sanità.
Per questo la vita media a Gaza è tragicamente bassa.
Anche in virtù delle perdite di guerra, perché questi ultimi 10 anni ci sono stati episodi di guerra guerreggiata almeno ogni 2 anni, e la guerra a bassa intensità, con lanci di missili e risposta con bombe, è stata praticamente continua.
C'è un accordo non scritto tra medici palestinesi e israeliani: ed è che, se c'è qualche intervento chirurgico complesso da fare, o qualche terapia più delicata, i bambini vengono trasferiti da Gaza verso gli ospedali israeliani, dove vengono curati benissimo, a patto che i genitori non li accompagnino, perché, essendo giovani, vengono considerati delle teste calde fino al compimento del quarantesimo anno di età.
Pertanto quando abbiamo dovuto mandare qualche bambino fuori dalla striscia perché ci mancava il materiale per curarlo o perché era un caso troppo complesso, li abbiamo visti partire accompagnati dal nonno o dalla nonna.
Il nostro obiettivo sarebbe stato quello di aiutare i colleghi, peraltro bravissimi, ad imparare le procedure complesse con cui noi abbiamo più familiarità, per diventare autonomi come i loro colleghi del Makassed, ma le difficoltà ambientali e le continue guerre, non ce l’hanno permesso.
Massa, 5 novembre 2023
Pierantonio Furfori
Post su facebook del 16 marzo 2023 di Pierantonio Furfori
L'ultimo bambino che abbiamo operato, poco prima di entrare in sala, si è fatto questo disegno sulla gamba. Un grande cuore ed una piccola vettura. Forse voleva essere un augurio: il cuore guarisce e va lontano con la sua automobile.
Anche il suo intervento è andato bene.
Era l'undicesimo paziente cardiochrurgico. È stata una settimana piena di imprevisti ed emozioni. Non abbiamo dormito molto, e abbiamo lavorato moltissimo.
Alla fine tutti i pazienti stanno bene.
Nell'altra foto si vede una ferita sul vetro delle scale del dormitorio.
Un proiettile vagante, durante l'ultima guerra terrestre lo ha trafitto.
Fortunatamente non c'era nessuno. Le autorità militari israeliane si sono scusate: un effetto collaterale non voluto. Gli ospedali non dovrebbero essere coinvolti nella guerra.
Tutte le volte che passo di lì, rifletto sull'inutilità della guerra, le cui vittime sono soprattutto i bambini sognatori come quello dell'altra foto.
Grazie per i pensieri gentili e per le preghiere.